|
L'incontro... 
Il 9 e il 10 febbraio aspettavamo un
ospite.
Nella nostra piccola città le classi quarte e quinte attendevano con
ansia qualcuno che avrebbe raccontato loro delle storie.
La sfida era
piuttosto ardua e noi insegnanti ne eravamo consapevoli; qualcuno conosceva bene
il calibro di chi sarebbe arrivato, altri, come me, semplicemente si
fidavano.
L'importante, mi dicevo, è che riesca a conquistare i ragazzi, non
solo quelli "facili da coinvolgere", ma quelli per i quali ogni giorno è una
sfida, quelli che con uno sguardo capiscono dove vuoi arrivare e subito dopo ti
fanno capire se intendono o meno arrivarci insieme a te..
Ed ecco finalmente
l'incontro: lui, il professor Filippetti, è un uomo garbato, sorridente, ti
parla affabilmente mescolando subito vita e lavoro, esperienze personali e
progetti; lo fa con la naturalezza di chi si trova tra amici, con la gioia di
chi intende raccontare per il piacere di condividere un dono grande.
Con lo
stesso sorriso accoglie i ragazzi che lo guardano di sottecchi e aspettano di
essere conquistati.
Senza troppi preamboli si accinge a raccontare loro la
prima delle storie di Andersen che riecheggeranno tra le mura dei nostri plessi
per i prossimi giorni: si tratta de "L'uomo di neve", cui il professor
Filippetti ha aggiunto il sottotitolo "ovvero, in cosa consiste il cuore
dell'io".
La racconta intonando la voce per caratterizzare i diversi
personaggi, dando loro poesia e spessore; questo colpisce molto l'uditorio. C'è
chi, a fine racconto, ammette di essersi sentito molto coinvolto; qualcuno
addirittura confessa di essersi sentito trasportare in un altro luogo, vicino al
freddo dell'uomo di neve, proprio lì, accanto alla finestra da cui si intravede
la stufa.
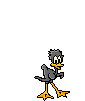 Segue, raccontata con la medesima intensità, la
storia de "Il brutto anatroccolo", "o del tu che risponde al cuore". Segue, raccontata con la medesima intensità, la
storia de "Il brutto anatroccolo", "o del tu che risponde al cuore".
Il
contenuto dei racconti è di una bellezza struggente e i ragazzi fanno proprio il
significato della parola-chiave "nostalgia", intesa proprio come dolore (-algia,
appunto) che deriva da una separazione e che può quindi essere placato solo da
un ricongiungimento ad una persona, un luogo.
Immediato l'aggancio
all'esperienza personale che ci porta ad individuare nella nostra vita momenti
di più o meno intensa nostalgia; ma come non approfondire ulteriormente pensando
a quel "raschiatoio di stufa" che costituiva l'anima dell'uomo di neve ed era la
causa della sua apparentemente inspiegabile nostalgia per essa? L'idea che
qualcosa dentro di noi (l'anima?) rimanda ad altro, passa da sé, perché la
simbologia è immediata nella sua semplicità.
Così come, chiamati ad
individuare la frase-chiave del secondo racconto, i ragazzi facilmente la
trovano: "Che importa se siamo nati in un pollaio, quando siamo usciti da un
uovo di cigno?".
L'invito è il medesimo, quello a pensare a sé stessi come
portatori di una ricchezza e di una bellezza tanto enorme quanto inconsapevole e
immeritata; dono, appunto.
 Il secondo
incontro si apre con un'altra storia; si tratta de "Il lino", sempre di
Andersen; ancora l'incontro con un cuore di bambino, innocente, speranzoso e un
po' ingenuo, la pianticella di lino; ancora l'esperienza del dolore che mette
alla prova perché appare gratuito, privo di motivazione; ancora un messaggio
finale: "La storia non finisce mai!". Il secondo
incontro si apre con un'altra storia; si tratta de "Il lino", sempre di
Andersen; ancora l'incontro con un cuore di bambino, innocente, speranzoso e un
po' ingenuo, la pianticella di lino; ancora l'esperienza del dolore che mette
alla prova perché appare gratuito, privo di motivazione; ancora un messaggio
finale: "La storia non finisce mai!".
 Da ultimo, il
professore che, come dicono i ragazzi, "sembra adulto ma parla come un bambino",
ci riserva una sorpresa: la lettura del capitolo XXI de "Il piccolo Principe" di
Saint Exupery. Da ultimo, il
professore che, come dicono i ragazzi, "sembra adulto ma parla come un bambino",
ci riserva una sorpresa: la lettura del capitolo XXI de "Il piccolo Principe" di
Saint Exupery.
Non conosco nessuno che, leggendo questo testo, sia rimasto
indifferente.
Non lo ritengo possibile.
Se sei un educatore per
professione, o semplicemente un genitore, dopo averlo letto la prima volta non
potrai non innamorartene e, magari, commuoverti ogni volta che ti capiterà di
nuovo sotto gli occhi.
Riuscire a catturare l'attenzione dei ragazzi
raccontando loro la lezione del piccolo principe e della sua amica volpe credo
sia un'esperienza davvero unica; "non si conoscono che le cose che si
addomesticano" e, naturalmente, "l'essenziale è invisibile agli occhi": non è
certo un gioco da ragazzi, è un modo di intendere la vita, una lezione per
tutti.
Grazie professor Filippetti, averla tra noi è stato un piacere e un
onore.
Grazie di averci avvicinato a dei testi tanto ricchi e tanto
preziosi.
Grazie di averci aiutato a crescere. E non parlo solo dei
ragazzi.
Emilia Cremonesi 
|

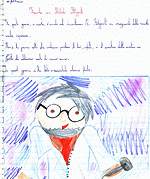


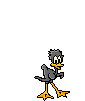 Segue, raccontata con la medesima intensità, la
storia de "Il brutto anatroccolo", "o del tu che risponde al cuore".
Segue, raccontata con la medesima intensità, la
storia de "Il brutto anatroccolo", "o del tu che risponde al cuore". Da ultimo, il
professore che, come dicono i ragazzi, "sembra adulto ma parla come un bambino",
ci riserva una sorpresa: la lettura del capitolo XXI de "Il piccolo Principe" di
Saint Exupery.
Da ultimo, il
professore che, come dicono i ragazzi, "sembra adulto ma parla come un bambino",
ci riserva una sorpresa: la lettura del capitolo XXI de "Il piccolo Principe" di
Saint Exupery. Cont@ttami
Cont@ttami
